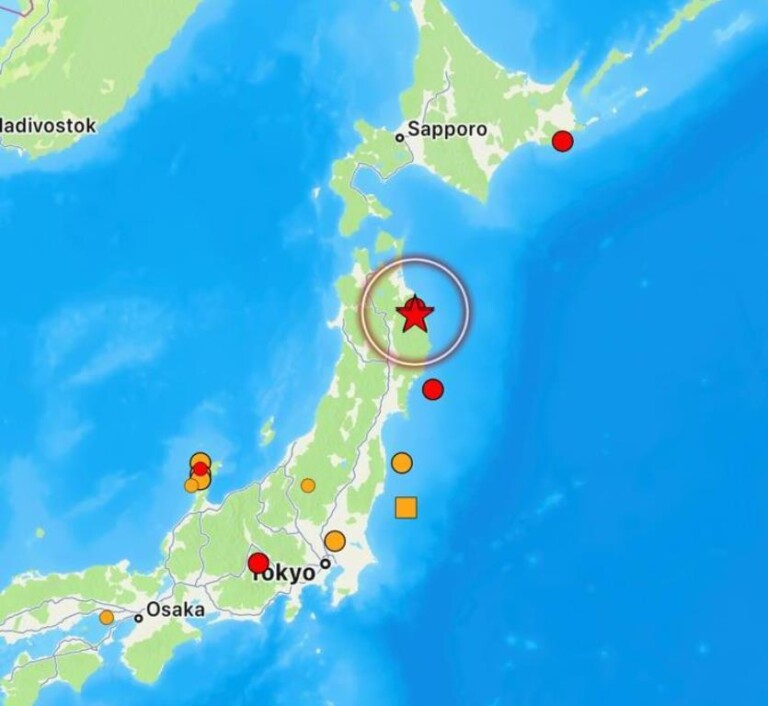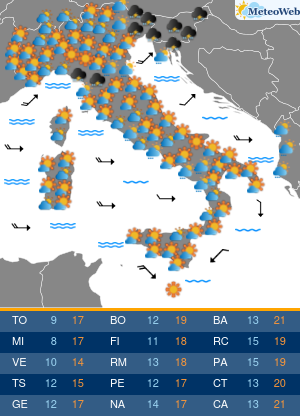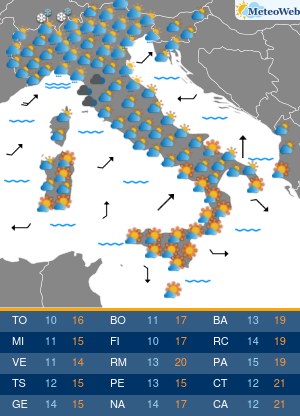Dopo il terremoto si riaccende il dibattito su terremoti e previsioni e, come era accaduto gia’ il 20 maggio, tornano in campo i modelli finora elaborati, ben 180 in tutto il mondo. Nessuno di essi, pero’, e’ finora mai stato adottato da un governo a fini operativi. ”I modelli previsionali vanno testati: ci sono tutte le possibilita’ di validarli con un approccio scientifico”, ha commentato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), Stefano Gresta. ”I modelli previsionali possono essere fatti dai ricercatori, anche dell’Ingv, il fatto – ha rilevato – e’ che poi vanno testati nella loro efficacia. Ci sono tutti gli elementi per verificarne la validita’ scientifica o meno”. I modelli previsionali sono all’esame della collaborazione internazionale Csep (Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability), una sorta di supervisore delle ricerche condotte in tutto il mondo sul problema della previsione.
”Usare il termine previsione non significa riferirsi alla possibilita’, calcolata al 100%, che un terremoto accada in un dato luogo in un tempo determinato”, ha spiegato il sismologo Warner Marzocchi, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e membro della collaborazione internazionale Csep (Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability), una sorta di supervisore delle ricerche condotte in tutto il mondo sul problema della previsione. Dei modelli di questo tipo, ad esempio, fa parte quello elaborato dal sismologo Giuliano Panza, dell’universita’ di Trieste e del Centro internazionale di fisica teorica (Ictp) di Trieste. Sono modelli, ha spiegato Marzocchi, che ”considerano aree molto estese e intervalli di tempo prolungati”. Per esempio, la previsione di un terremoto nel Nord si riferisce, secondo il modello, ad un’area che si estende dalla Slovenia alla Liguria, fino al Lazio e il periodo considerato e’ di sei mesi. Il modello russo circoscrive una zona che comprende Calabria e Sicilia, indicando il rischio di un sisma di magnitudo 6. ”Per ora – ha osservato Marzocchi – non ci sono prove convincenti che questo modelli dicano qualcosa in piu’ rispetto a quello che sappiamo adesso”. ”Esistono diverse mappe della probabilita’ dei terremoti a cinque o a dieci anni”, ha aggiunto Marzocchi. Una strategia, ad esempio, consiste nell’analizzare i ‘cluster’, ossia sequenze di terremoti ravvicinate nel tempo e nello spazio. Vicini, ha spiegato Marzocchi, nel senso che possono essere separati da un intervallo di poche ore (come nel caso del terremoto di Colfiorito del 1997 o del Belice nel 1968), oppure da un intervallo di mesi (come nel 1976 in Friuli) o addirittura di anni. ”Anche in quest’ultimo caso – ha osservato – si tratta di intervalli brevi su una scala geologica”.
La probabilita’ che si verifichi o meno un terremoto diventa uno strumento operativo quando si trasforma in mappe della pericolosita’. ”La pericolosita’ indica la probabilita’ che avvenga uno scuotimento”, ha spiegato il sismologo Alessandro Amato. ”Quando la mappa della pericolosita’ indica che una zona e’ a basso rischio sismico – ha rilevato Gresta – non significa che la zona sia caratterizzata da piccoli terremoti, ma che i terremoti avvengono a intervalli di secoli e non a distanza di decenni”. E la mappa di pericolosita’ prodotta dall’Ingv e pubblicata nel 2004 ”indica che i terremoti in Emilia sono compatibili”. Una cosa ben diversa e’ la mappa del rischio. Questa, ha detto Amato, ”indica il prodotto della probabilita’ di uno scuotimento e della vulnerabilita’ degli edifici. In Italia – ha concluso – il problema e’ la vulnerabilita’ degli edifici”.