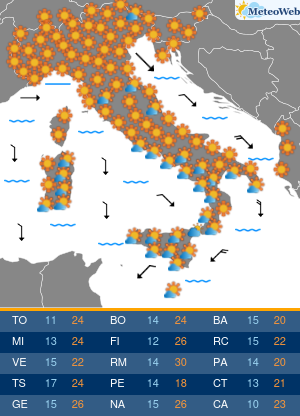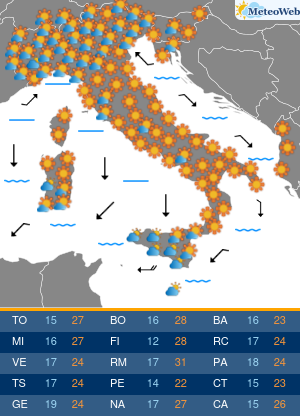La catena montuosa dell’Himalaya, la più imponente della Terra, e l’esteso altopiano tibetano, godono di uno dei climi più peculiari del pianeta, fortemente influenzati dall’elevata altitudine. Prima di analizzare le singole caratteristiche climatiche dell’area himalayana e tibetana bisogna tenere conto della latitudine. Questo fattore, difatti, ha un importanza notevole per capire le dinamiche del complesso sistema climatico dell’ampia regione asiatica. Sia l’Himalaya che il grande altopiano del Tibet ricadono nella fascia climatica sub-tropicale, quella che per gran parte dell’anno viene influenzata dai regimi anticicloni dinamici permanenti, che segnano la linea di confine tra l’area tropicale e quella temperata delle medie latitudini. Proprio per questo, durante l’inverno boreale, le correnti occidentali delle medie latitudini scorrono al di sopra dell’imponente barriera montuosa, favorendo l’apporto di precipitazioni, a dir la verità non particolarmente abbondanti, prodotte dall’affondo di saccature in alta quota inserite dentro l’intenso “getto” occidentale.
La catena montuosa dell’Himalaya, la più imponente della Terra, e l’esteso altopiano tibetano, godono di uno dei climi più peculiari del pianeta, fortemente influenzati dall’elevata altitudine. Prima di analizzare le singole caratteristiche climatiche dell’area himalayana e tibetana bisogna tenere conto della latitudine. Questo fattore, difatti, ha un importanza notevole per capire le dinamiche del complesso sistema climatico dell’ampia regione asiatica. Sia l’Himalaya che il grande altopiano del Tibet ricadono nella fascia climatica sub-tropicale, quella che per gran parte dell’anno viene influenzata dai regimi anticicloni dinamici permanenti, che segnano la linea di confine tra l’area tropicale e quella temperata delle medie latitudini. Proprio per questo, durante l’inverno boreale, le correnti occidentali delle medie latitudini scorrono al di sopra dell’imponente barriera montuosa, favorendo l’apporto di precipitazioni, a dir la verità non particolarmente abbondanti, prodotte dall’affondo di saccature in alta quota inserite dentro l’intenso “getto” occidentale.
 In questo periodo, molto spesso, il ramo principale della “corrente a getto sub-tropicale”, scendendo di latitudine, va ad investire le principali cime dell’Himalaya, oltre i 7000-8000 metri, incluse quelle molto famose, come il K2 o la mitica Everest. Durante la stagione invernale e nel periodo primaverile le vette himalayane, molto spesso, fanno i conti con il cosiddetto asse inferiore della “Jet Stream”, che impattando con le vette, determina considerevoli turbolenze, con condizioni eoliche davvero estreme. La velocità del vento può raggiungere picchi talmente violenti da riuscire a sollevare enormi quantità di neve depositata, trasportandola da un versante all’altro, con ingentissimi accumuli eolici che spesso possono generare disastrose valanghe sulle vallate sottostanti. Alla media troposfera (quota di 500 hPa), il promontorio anticiclonico si colloca alla latitudine di 14° nord. La linea del promontorio in quota si sposta gradualmente verso nord, e a metà Giugno è posizionata sopra il Tibet.
In questo periodo, molto spesso, il ramo principale della “corrente a getto sub-tropicale”, scendendo di latitudine, va ad investire le principali cime dell’Himalaya, oltre i 7000-8000 metri, incluse quelle molto famose, come il K2 o la mitica Everest. Durante la stagione invernale e nel periodo primaverile le vette himalayane, molto spesso, fanno i conti con il cosiddetto asse inferiore della “Jet Stream”, che impattando con le vette, determina considerevoli turbolenze, con condizioni eoliche davvero estreme. La velocità del vento può raggiungere picchi talmente violenti da riuscire a sollevare enormi quantità di neve depositata, trasportandola da un versante all’altro, con ingentissimi accumuli eolici che spesso possono generare disastrose valanghe sulle vallate sottostanti. Alla media troposfera (quota di 500 hPa), il promontorio anticiclonico si colloca alla latitudine di 14° nord. La linea del promontorio in quota si sposta gradualmente verso nord, e a metà Giugno è posizionata sopra il Tibet.
 Durante i mesi del monsone estivo da SO, a differenza della situazione sinottica invernale, la catena himalayana si trova sotto l’influsso delle correnti orientali, meglio note come “Easterly Jet” (tipico flusso nella fascia tropicale), alla superficie isobarica di 200 hPa, nell’alta troposfera. L’altopiano tibetano, con la sua notevole altitudine media di circa 5000 metri, fortemente riscaldato dalla radiazione solare, favorisce l’insorgenza di una robusta area di alta pressioni, il famoso anticiclone tibetano, nell’alta troposfera, che genera a sua volta correnti orientali in quota su tutto il sub-continente indiano nell’estate boreale. Tale situazione permane fino ai primi giorni del mese di Ottobre, quando con la cessazione del regime monsonico estivo, l’arretramento verso sud dell’ITCZ sull’oceano Indiano, e la contemporanea discesa di latitudine del ramo principale della “Jet Stream”, si innesca una decisa variazione dei venti alla quota di 200 hpa, che tendono a disporsi nuovamente dai quadranti occidentali.
Durante i mesi del monsone estivo da SO, a differenza della situazione sinottica invernale, la catena himalayana si trova sotto l’influsso delle correnti orientali, meglio note come “Easterly Jet” (tipico flusso nella fascia tropicale), alla superficie isobarica di 200 hPa, nell’alta troposfera. L’altopiano tibetano, con la sua notevole altitudine media di circa 5000 metri, fortemente riscaldato dalla radiazione solare, favorisce l’insorgenza di una robusta area di alta pressioni, il famoso anticiclone tibetano, nell’alta troposfera, che genera a sua volta correnti orientali in quota su tutto il sub-continente indiano nell’estate boreale. Tale situazione permane fino ai primi giorni del mese di Ottobre, quando con la cessazione del regime monsonico estivo, l’arretramento verso sud dell’ITCZ sull’oceano Indiano, e la contemporanea discesa di latitudine del ramo principale della “Jet Stream”, si innesca una decisa variazione dei venti alla quota di 200 hpa, che tendono a disporsi nuovamente dai quadranti occidentali.
 Grazie all’instaurazione del flusso occidentale nell’alta troposfera d’inverno le precipitazioni maggiori, quasi sempre a carattere nevoso data l’altitudine, si verificano sull’Himalaya occidentale (ove la barriera montuosa himalayana agevola un notevole effetto “stau” che favorisce la nascita di imponenti annuvolamenti orografici sul versante occidentale), mentre il settore orientale si trova maggiormente riparato. Ma il versante orientale della catena himalayana, malgrado la presenza delle correnti sfavorevoli in alta quota, riceve un picco di massime precipitazioni tra i mesi di Aprile e soprattutto Maggio, quando cominciano ad affluire masse d’aria molto più umide, nei medi e bassi strati, che salgono direttamente dal Golfo del Bengala. Nell’intera regione orientale himalayana i massimi valori della precipitazione si localizzano nelle zone costiere meridionali cinesi, con picchi di ben oltre i 2000 mm a Kwangsi e Taiwan. Ma spostandoci gradualmente sempre più verso nord si nota come il potenziale pluviometrico inizi drasticamente a diminuire, arrivando sino ai 250 mm annui nelle regioni di Kansu, ai limiti del clima semi-desertico. Andando sempre più a nord, sconfinando dentro la Mongolia interna, Qinghai riceve meno di 1000 mm, mentre nel cuore del deserto del Gobi ci sono località che possono ricevere fino a 5-10 mm nel corso dell’anno.
Grazie all’instaurazione del flusso occidentale nell’alta troposfera d’inverno le precipitazioni maggiori, quasi sempre a carattere nevoso data l’altitudine, si verificano sull’Himalaya occidentale (ove la barriera montuosa himalayana agevola un notevole effetto “stau” che favorisce la nascita di imponenti annuvolamenti orografici sul versante occidentale), mentre il settore orientale si trova maggiormente riparato. Ma il versante orientale della catena himalayana, malgrado la presenza delle correnti sfavorevoli in alta quota, riceve un picco di massime precipitazioni tra i mesi di Aprile e soprattutto Maggio, quando cominciano ad affluire masse d’aria molto più umide, nei medi e bassi strati, che salgono direttamente dal Golfo del Bengala. Nell’intera regione orientale himalayana i massimi valori della precipitazione si localizzano nelle zone costiere meridionali cinesi, con picchi di ben oltre i 2000 mm a Kwangsi e Taiwan. Ma spostandoci gradualmente sempre più verso nord si nota come il potenziale pluviometrico inizi drasticamente a diminuire, arrivando sino ai 250 mm annui nelle regioni di Kansu, ai limiti del clima semi-desertico. Andando sempre più a nord, sconfinando dentro la Mongolia interna, Qinghai riceve meno di 1000 mm, mentre nel cuore del deserto del Gobi ci sono località che possono ricevere fino a 5-10 mm nel corso dell’anno.
 Un’aridità molto aspra che ha dato origine ad uno dei più grandi deserti del continente asiatico. Sempre durante il periodo estivo, l’andamento dei venti alle varie quote può divenire molto complesso, di difficile interpretazione, a causa della particolare orografia dell’area tibetana che riesce ad influenzare l’andamento delle correnti eoliche anche a quote più elevate (fino a 6000 metri), con notevoli ripercussioni nell’ambito della distribuzione delle precipitazioni, che possono risentire pesantemente di tale irregolarità. In genere sono i versanti meridionali a ricevere i massimi accumuli, usufruendo di quel poco di umidità che sconfina dalla barriera himalayana. Più a nord, invece, gli apporti umidi dai quadranti meridionali tendono sempre più a diminuire, fino ad assumere il carattere tipico dei climi desertici o semi-desertici. Ancora più interessante e l’analisi del campo termico del clima tibetano che presenta tutte le caratteristiche dei climi continentali caratteristici dell’Asia centrale. Le escursioni termiche annue sono veramente elevatissime, tanto che le differenze fra le medie di Giugno e quelle di Gennaio si aggirano oltre i +20°C. La temperatura media nel mese di Luglio non si discosta molto da Giugno o dalle medie di Agosto, ciò è da addebitare alla frequente nuvolosità che caratterizza il periodo estivo, a seguito dell’afflusso di masse d’aria molto umide sospinte dal flusso monsonico sud-occidentale. In inverno invece le forti inversioni termiche notturne e il forte irragiamento favoriscono diffuse gelate, con valori che possono scendere sotto i -20°C. A Lhasa, l’escursione termica media giornaliera è dell’ordine di +15° d’estate e di quasi +20° d’inverno, segno dell’estrema aridità invernale. Il mese più piovoso a Lhasa è luglio, dove possono cadere fino a 120 mm, mentre nel periodo che va da Ottobre ad Aprile non si superano nemmeno i 20 mm. La città di Lhasa si trova a circa 3650 metri di altezza, nel cuore dell’altopiano del Tibet. Intorno ad essa si ergono due catene montuose quasi parallele, con vette anche di 5000 metri. Nel mezzo di queste si stende una pianura alluvionale dove scorre il letto del fiume Kyi-chu, principale affluente del Brahmaputra.
Un’aridità molto aspra che ha dato origine ad uno dei più grandi deserti del continente asiatico. Sempre durante il periodo estivo, l’andamento dei venti alle varie quote può divenire molto complesso, di difficile interpretazione, a causa della particolare orografia dell’area tibetana che riesce ad influenzare l’andamento delle correnti eoliche anche a quote più elevate (fino a 6000 metri), con notevoli ripercussioni nell’ambito della distribuzione delle precipitazioni, che possono risentire pesantemente di tale irregolarità. In genere sono i versanti meridionali a ricevere i massimi accumuli, usufruendo di quel poco di umidità che sconfina dalla barriera himalayana. Più a nord, invece, gli apporti umidi dai quadranti meridionali tendono sempre più a diminuire, fino ad assumere il carattere tipico dei climi desertici o semi-desertici. Ancora più interessante e l’analisi del campo termico del clima tibetano che presenta tutte le caratteristiche dei climi continentali caratteristici dell’Asia centrale. Le escursioni termiche annue sono veramente elevatissime, tanto che le differenze fra le medie di Giugno e quelle di Gennaio si aggirano oltre i +20°C. La temperatura media nel mese di Luglio non si discosta molto da Giugno o dalle medie di Agosto, ciò è da addebitare alla frequente nuvolosità che caratterizza il periodo estivo, a seguito dell’afflusso di masse d’aria molto umide sospinte dal flusso monsonico sud-occidentale. In inverno invece le forti inversioni termiche notturne e il forte irragiamento favoriscono diffuse gelate, con valori che possono scendere sotto i -20°C. A Lhasa, l’escursione termica media giornaliera è dell’ordine di +15° d’estate e di quasi +20° d’inverno, segno dell’estrema aridità invernale. Il mese più piovoso a Lhasa è luglio, dove possono cadere fino a 120 mm, mentre nel periodo che va da Ottobre ad Aprile non si superano nemmeno i 20 mm. La città di Lhasa si trova a circa 3650 metri di altezza, nel cuore dell’altopiano del Tibet. Intorno ad essa si ergono due catene montuose quasi parallele, con vette anche di 5000 metri. Nel mezzo di queste si stende una pianura alluvionale dove scorre il letto del fiume Kyi-chu, principale affluente del Brahmaputra.