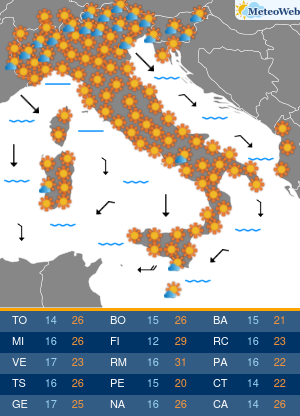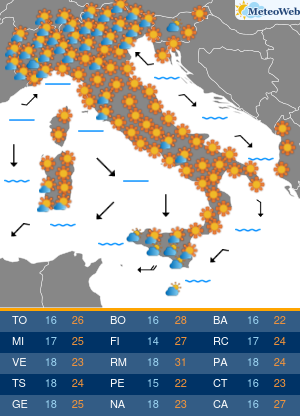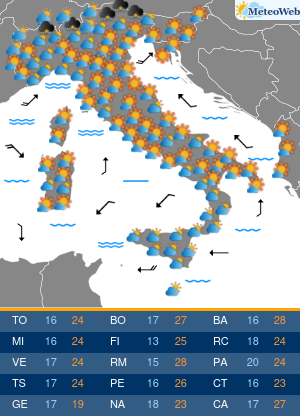La Calotta glaciale dell’Antartide è la più antica ed estesa del pianeta, tanto da costituire a tutt’oggi la più grande riserva naturale d’acqua dolce della Terra. Grazie alla sua considerevole estensione essa, da oltre 20 milioni di anni, regola il bilancio termico della Terra, influenzando in modo pesante la complessa macchina climatica. La Calotta antartica rappresenta la principale sorgente fredda del complesso sistema termodinamico della Terra e un patrimonio naturale davvero inestimabile per il pianeta. Osservata dai satelliti appare come una sterminata distesa di bianco che riesce a riflettere i raggi solari, grazie al cosiddetto effetto “Albedo”. Difatti, grazie a tutto questo bianco, la Calotta del Polo Sud riesce a respingere verso lo spazio buona parte dell’energia trasmessa dai raggi solari. Questa grande riflettività della Calotta riesce a renderla abbastanza stabile nel tempo. Ma la Calotta antartica, con la sua enorme mole, riesce ad esercitare una profonda influenza sul clima terrestre, e non solo sull’emisfero australe. Diversi studi avrebbero confermato l’influenza diretta della Calotta del Polo Sud sull’equilibrio termico globale e sulla circolazione profonda degli oceani. I ghiacci della Calotta del Polo Sud rappresentano un importante laboratorio per conoscere la storia e tutti i segreti della macchina climatica. Proprio grazie allo studio dei ghiacci della Calotta polare antartica è stato possibile studiare i mutamenti climatici avvenuti sulla Terra negli ultimi 160 mila anni.
La Calotta glaciale dell’Antartide è la più antica ed estesa del pianeta, tanto da costituire a tutt’oggi la più grande riserva naturale d’acqua dolce della Terra. Grazie alla sua considerevole estensione essa, da oltre 20 milioni di anni, regola il bilancio termico della Terra, influenzando in modo pesante la complessa macchina climatica. La Calotta antartica rappresenta la principale sorgente fredda del complesso sistema termodinamico della Terra e un patrimonio naturale davvero inestimabile per il pianeta. Osservata dai satelliti appare come una sterminata distesa di bianco che riesce a riflettere i raggi solari, grazie al cosiddetto effetto “Albedo”. Difatti, grazie a tutto questo bianco, la Calotta del Polo Sud riesce a respingere verso lo spazio buona parte dell’energia trasmessa dai raggi solari. Questa grande riflettività della Calotta riesce a renderla abbastanza stabile nel tempo. Ma la Calotta antartica, con la sua enorme mole, riesce ad esercitare una profonda influenza sul clima terrestre, e non solo sull’emisfero australe. Diversi studi avrebbero confermato l’influenza diretta della Calotta del Polo Sud sull’equilibrio termico globale e sulla circolazione profonda degli oceani. I ghiacci della Calotta del Polo Sud rappresentano un importante laboratorio per conoscere la storia e tutti i segreti della macchina climatica. Proprio grazie allo studio dei ghiacci della Calotta polare antartica è stato possibile studiare i mutamenti climatici avvenuti sulla Terra negli ultimi 160 mila anni.
 I ghiacci conservano anche le polveri di grandi eruzioni vulcaniche avvenute sulla Terra, meteoriti, pollini e sostanze inquinanti. Questi dati una volta elaborati ci permettono di capire le dinamiche che hanno agito sui cambiamenti climatici che hanno contraddistinto la storia recente della Terra. La Calotta del Polo Sud è di sicuro il posto più gelido e inospitale del nostro pianeta. Tutto l’anno, sopra il gelidissimo Plateau dell’Antartide, domina l’anticiclone termico permanente antartico, che assicura in genere cieli limpidi e sereni. Questo potente anticiclone è prodotto da uno spesso strato di inversione termica che si origina sopra il Plateau ghiacciato e permette all’aria gelida e molto pesante di stagnare sopra l’immensa distesa di ghiacci (per l’effetto Albedo), inibendo lo sviluppo di qualsiasi tipo di moto convettivo. Proprio qui dove domina il potente anticiclone termico permanente antartico (con valori barici che possono raggiungere i 1040-1050 hpa), lo spesso strato di inversione termica creato dall’Albedo mantiene costante e omogeneo l’andamento termico da Aprile a Settembre, periodo in cui prende il sopravvento il cosiddetto “Kernlose winter”, un forte raffreddamento che si realizza con la scomparsa del sole sotto l’orizzonte e rimane pressoché costante per tutto il periodo invernale, con scarsissime variazioni del campo termico nel cuore del continente antartico.
I ghiacci conservano anche le polveri di grandi eruzioni vulcaniche avvenute sulla Terra, meteoriti, pollini e sostanze inquinanti. Questi dati una volta elaborati ci permettono di capire le dinamiche che hanno agito sui cambiamenti climatici che hanno contraddistinto la storia recente della Terra. La Calotta del Polo Sud è di sicuro il posto più gelido e inospitale del nostro pianeta. Tutto l’anno, sopra il gelidissimo Plateau dell’Antartide, domina l’anticiclone termico permanente antartico, che assicura in genere cieli limpidi e sereni. Questo potente anticiclone è prodotto da uno spesso strato di inversione termica che si origina sopra il Plateau ghiacciato e permette all’aria gelida e molto pesante di stagnare sopra l’immensa distesa di ghiacci (per l’effetto Albedo), inibendo lo sviluppo di qualsiasi tipo di moto convettivo. Proprio qui dove domina il potente anticiclone termico permanente antartico (con valori barici che possono raggiungere i 1040-1050 hpa), lo spesso strato di inversione termica creato dall’Albedo mantiene costante e omogeneo l’andamento termico da Aprile a Settembre, periodo in cui prende il sopravvento il cosiddetto “Kernlose winter”, un forte raffreddamento che si realizza con la scomparsa del sole sotto l’orizzonte e rimane pressoché costante per tutto il periodo invernale, con scarsissime variazioni del campo termico nel cuore del continente antartico.
 Per oltre 6-7 mesi di fila, in genere da Aprile a Settembre, le temperature nelle zone centrali del Plateau antartico restano inchiodate sotto i -60°C -70°C. Il “Kernlose winter” difatti rappresenta la grande peculiarità del clima antartico, visto che è quasi sconosciuto nell’emisfero boreale, tranne che per alcune ristrette zone dell’altopiano ghiacciato della Groenlandia, dove il fenomeno risulta ben più attenuato e regolare rispetto all’Antartide. Sovente il “Kernlose winter” si protende fino alla fine del mese di Settembre e all’inizio di Ottobre, prima che lungo le coste antartiche si originano i profondissimi cicloni extratropicali sub-polari (possono presentare minimi di 940-930 hpa) che richiamano correnti di matrice oceanica, più temperate e umide, che possono penetrare fin dentro il Plateau, determinando dei rialzi termici che vanno a rompere lo strato di inversione termica che ha mantenuto in vita il “Kernlose winter”, con un conseguente rinforzo dei venti. Pur essendo l’unico continente della Terra circondato da ben tre oceani, avendo a disposizione una grande quantità di acqua e vapore acqueo pronto ad essere trasferito nella troposfera, essa rimane quasi sempre ghiacciata e mai disponibile in forma liquida.
Per oltre 6-7 mesi di fila, in genere da Aprile a Settembre, le temperature nelle zone centrali del Plateau antartico restano inchiodate sotto i -60°C -70°C. Il “Kernlose winter” difatti rappresenta la grande peculiarità del clima antartico, visto che è quasi sconosciuto nell’emisfero boreale, tranne che per alcune ristrette zone dell’altopiano ghiacciato della Groenlandia, dove il fenomeno risulta ben più attenuato e regolare rispetto all’Antartide. Sovente il “Kernlose winter” si protende fino alla fine del mese di Settembre e all’inizio di Ottobre, prima che lungo le coste antartiche si originano i profondissimi cicloni extratropicali sub-polari (possono presentare minimi di 940-930 hpa) che richiamano correnti di matrice oceanica, più temperate e umide, che possono penetrare fin dentro il Plateau, determinando dei rialzi termici che vanno a rompere lo strato di inversione termica che ha mantenuto in vita il “Kernlose winter”, con un conseguente rinforzo dei venti. Pur essendo l’unico continente della Terra circondato da ben tre oceani, avendo a disposizione una grande quantità di acqua e vapore acqueo pronto ad essere trasferito nella troposfera, essa rimane quasi sempre ghiacciata e mai disponibile in forma liquida.
 Al contrario di quanto si pensa proprio nel periodo invernale (inverno australe) l’attività ciclonica sub-polare diventa molto più intensa, quando l’ingerenza delle correnti umide oceaniche si fa strada all’interno del continente. Proprio in questo periodo dell’anno i sistemi frontali annessi ai profondissimi cicloni extratropicali dei mari antartici riescono a sconfinare fino al cuore del Plateau del continente australe con i loro sistemi nuvolosi, apportando alle volte pure delle residue precipitazioni nevose. In larga parte le precipitazioni che interessano il Plateau antartico sono costituite da piccoli fiocchi di neve farinosa ghiacciata e aghi di ghiaccio, come quelli rilevati in molte basi nel cuore del continente ricoperto dai ghiacci. Prendendo in esame i dati d’archivio della base russa di Vostok (una delle più famose per la climatologia antartica), scopriamo che nel periodo 1958-2004 la media pluviometrica si attesterebbe intorno ai 19.9 mm. In 492 mesi rilevati (fino al 2004) se ne contano 102 con assenza totale di precipitazioni.
Al contrario di quanto si pensa proprio nel periodo invernale (inverno australe) l’attività ciclonica sub-polare diventa molto più intensa, quando l’ingerenza delle correnti umide oceaniche si fa strada all’interno del continente. Proprio in questo periodo dell’anno i sistemi frontali annessi ai profondissimi cicloni extratropicali dei mari antartici riescono a sconfinare fino al cuore del Plateau del continente australe con i loro sistemi nuvolosi, apportando alle volte pure delle residue precipitazioni nevose. In larga parte le precipitazioni che interessano il Plateau antartico sono costituite da piccoli fiocchi di neve farinosa ghiacciata e aghi di ghiaccio, come quelli rilevati in molte basi nel cuore del continente ricoperto dai ghiacci. Prendendo in esame i dati d’archivio della base russa di Vostok (una delle più famose per la climatologia antartica), scopriamo che nel periodo 1958-2004 la media pluviometrica si attesterebbe intorno ai 19.9 mm. In 492 mesi rilevati (fino al 2004) se ne contano 102 con assenza totale di precipitazioni.
 Il mese in cui non si osservano precipitazioni è Dicembre, la cui media si attesta sui 0.6 mm. Maggio è invece il mese più piovoso per Vostok, con una media di ben 2.6 mm. I mesi con più precipitazioni sono sempre quelli invernali. Gli estremi annui pluviometrici variano dai 0.2 mm del 1982 e 1995 ai 66.4 mm del 1958. Il mese più abbondante è stato il Giugno 1958, con ben 18.6 mm. Records tuttora imbattuti nella base russa. Occorre però anche ricordare che spesso gli accumuli pluviometrici vengono sottostimati dai forti venti “Catabatici” (venti tempestosi, possono superare pure i 300 km/h, prodotti dai notevolissimi divari di densità, e quindi di pressione atmosferica, fra le gelide masse d’aria che stazionano sopra il Plateau Antartico, dove si ha un potente anticiclone permanente tutto l’anno, con l’aria più mite presente sui mari che bagnano il Polo Sud, dove invece prevalgono profondi sistemi depressioni, con minimi che possono sprofondare sotto i 940 hpa, che sfrecciano per i mari del sud, portando continue tempeste, tanto da rendere questi bacini tra i più tempestosi del pianeta visto la totale assenza di terre emerse.
Il mese in cui non si osservano precipitazioni è Dicembre, la cui media si attesta sui 0.6 mm. Maggio è invece il mese più piovoso per Vostok, con una media di ben 2.6 mm. I mesi con più precipitazioni sono sempre quelli invernali. Gli estremi annui pluviometrici variano dai 0.2 mm del 1982 e 1995 ai 66.4 mm del 1958. Il mese più abbondante è stato il Giugno 1958, con ben 18.6 mm. Records tuttora imbattuti nella base russa. Occorre però anche ricordare che spesso gli accumuli pluviometrici vengono sottostimati dai forti venti “Catabatici” (venti tempestosi, possono superare pure i 300 km/h, prodotti dai notevolissimi divari di densità, e quindi di pressione atmosferica, fra le gelide masse d’aria che stazionano sopra il Plateau Antartico, dove si ha un potente anticiclone permanente tutto l’anno, con l’aria più mite presente sui mari che bagnano il Polo Sud, dove invece prevalgono profondi sistemi depressioni, con minimi che possono sprofondare sotto i 940 hpa, che sfrecciano per i mari del sud, portando continue tempeste, tanto da rendere questi bacini tra i più tempestosi del pianeta visto la totale assenza di terre emerse.