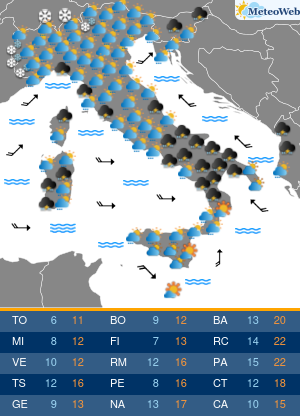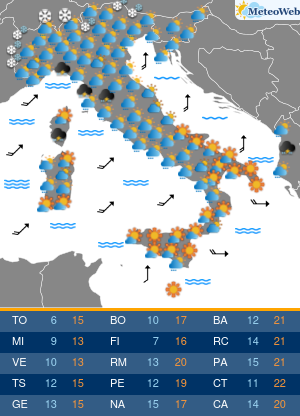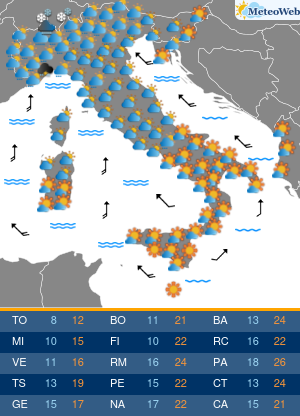L’ennesima rimonta d’aria molto mite, d’estrazione sub-tropicale continentale, che in queste ore sta risalendo l’Italia, oltre a mantenere il clima insolitamente tiepido su gran parte delle nostre regioni, sta anche contribuendo a sospingere verso i cieli italiani un immensa nuvola di polvere desertica sahariana. Difatti, nelle ultime 24 ore, in seno al flusso d’aria molto mite e umida d’estrazione sub-tropicale continentale, in risalita dall’entroterra desertico algerino, si è inserita una vasta nuvola di pulviscolo desertico che dalla regione del Grande Erg orientale (cuore del deserto sabbioso dell’Algeria orientale) si è mossa fin verso l’Italia settentrionale e le Alpi, dando luogo all’affascinante fenomeno della “neve rossa” caduta nella giornata di ieri su diversi passi alpini. Le nuvole di polvere provenienti dal Sahara tendono ad invadere le regioni italiane quando sull’entroterra nord-africano, fra l’area del Maghreb e la Tunisia e la Libia, si vengono a strutturare delle circolazioni depressionarie autonome, in progressiva evoluzione in “CUT-OFF”, meglio inquadrate dalla “depressione algerina”: una delle principali figure bariche che condiziona, a volte anche in maniera pesante, il tempo sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia.
L’ennesima rimonta d’aria molto mite, d’estrazione sub-tropicale continentale, che in queste ore sta risalendo l’Italia, oltre a mantenere il clima insolitamente tiepido su gran parte delle nostre regioni, sta anche contribuendo a sospingere verso i cieli italiani un immensa nuvola di polvere desertica sahariana. Difatti, nelle ultime 24 ore, in seno al flusso d’aria molto mite e umida d’estrazione sub-tropicale continentale, in risalita dall’entroterra desertico algerino, si è inserita una vasta nuvola di pulviscolo desertico che dalla regione del Grande Erg orientale (cuore del deserto sabbioso dell’Algeria orientale) si è mossa fin verso l’Italia settentrionale e le Alpi, dando luogo all’affascinante fenomeno della “neve rossa” caduta nella giornata di ieri su diversi passi alpini. Le nuvole di polvere provenienti dal Sahara tendono ad invadere le regioni italiane quando sull’entroterra nord-africano, fra l’area del Maghreb e la Tunisia e la Libia, si vengono a strutturare delle circolazioni depressionarie autonome, in progressiva evoluzione in “CUT-OFF”, meglio inquadrate dalla “depressione algerina”: una delle principali figure bariche che condiziona, a volte anche in maniera pesante, il tempo sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia.
 La “depressione algerina” si forma ogni volta che aria fredda e piuttosto umida di origine atlantica riesce a penetrare nel cuore dell’Africa nord-occidentale, tra l’entroterra desertico del Marocco e dell’Algeria, situazione che capita di frequente quando l’anticiclone oceanico (alta pressione delle Azzorre) decide di estendere un promontorio verso le alte latitudini, in pieno oceano. Essa si sviluppa allorquando masse d’aria fredde e umide, di estrazione oceanica, che scivolano da NO o N-NO, lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, riuscendo a penetrare fino sull’entroterra algerino, in pieno deserto sahariano, dalla costa marocchina, intrufolandosi a sud della catena montuosa dell’Atlante. Qui le masse d’aria umide atlantiche interagiscono rapidamente con l’aria calda e molto secca preesistente in loco, innescando una complessa circolazione a gomito, a sud dell’Atlante algerino, la quale, dopo essersi intensificata, tende a chiudersi ai piedi della già citata catena montuosa, generando un minimo barico secondario nei bassi strati, sottovento ai rilievi (per questo si parla anche di minimo orografico).
La “depressione algerina” si forma ogni volta che aria fredda e piuttosto umida di origine atlantica riesce a penetrare nel cuore dell’Africa nord-occidentale, tra l’entroterra desertico del Marocco e dell’Algeria, situazione che capita di frequente quando l’anticiclone oceanico (alta pressione delle Azzorre) decide di estendere un promontorio verso le alte latitudini, in pieno oceano. Essa si sviluppa allorquando masse d’aria fredde e umide, di estrazione oceanica, che scivolano da NO o N-NO, lungo il bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, riuscendo a penetrare fino sull’entroterra algerino, in pieno deserto sahariano, dalla costa marocchina, intrufolandosi a sud della catena montuosa dell’Atlante. Qui le masse d’aria umide atlantiche interagiscono rapidamente con l’aria calda e molto secca preesistente in loco, innescando una complessa circolazione a gomito, a sud dell’Atlante algerino, la quale, dopo essersi intensificata, tende a chiudersi ai piedi della già citata catena montuosa, generando un minimo barico secondario nei bassi strati, sottovento ai rilievi (per questo si parla anche di minimo orografico).
 L’area di bassa pressione una volta formata tende ad approfondirsi, venendo a sua volta alimentata dalle umide e fresche correnti oceaniche che riescono a penetrare fino al cuore del Sahara algerino, con venti da NO e O-NO che entrano dalla costa atlantica marocchina. Solitamente, quando abbiamo un forte “getto” in quota, con una direttrice principale da O-NO e NO, il minimo barico orografico si forma sulla vasta regione del Maghreb, al confine tra il Marocco e l’Algeria occidentale, a sud dell’alto Atlante e della catena dell’Atlante sahariano, tra le città di Bechar, Ain-Sefra, Ghardaia e Touggourt. L’area di bassa pressione solitamente porta severe ondate di maltempo tra Marocco e Algeria, con piogge e spesso anche intense manifestazioni temporalesche, specie nella stagione autunnale. Una volta formata la “depressione algerina” tenderà a richiamare dall’entroterra desertico libico intense correnti meridionali da Sud e SE, pronte a risalire il basso Mediterraneo ed i mari italiani, mentre l’inasprimento del “gradiente barico orizzontale” indotto dallo stesso processo ciclogenetico algerino determina un sensibile rinforzo della ventilazione occidentale sul bordo meridionale della giovane area depressionaria che amplifica il flusso d’origine atlantica che entra dalla costa marocchina.
L’area di bassa pressione una volta formata tende ad approfondirsi, venendo a sua volta alimentata dalle umide e fresche correnti oceaniche che riescono a penetrare fino al cuore del Sahara algerino, con venti da NO e O-NO che entrano dalla costa atlantica marocchina. Solitamente, quando abbiamo un forte “getto” in quota, con una direttrice principale da O-NO e NO, il minimo barico orografico si forma sulla vasta regione del Maghreb, al confine tra il Marocco e l’Algeria occidentale, a sud dell’alto Atlante e della catena dell’Atlante sahariano, tra le città di Bechar, Ain-Sefra, Ghardaia e Touggourt. L’area di bassa pressione solitamente porta severe ondate di maltempo tra Marocco e Algeria, con piogge e spesso anche intense manifestazioni temporalesche, specie nella stagione autunnale. Una volta formata la “depressione algerina” tenderà a richiamare dall’entroterra desertico libico intense correnti meridionali da Sud e SE, pronte a risalire il basso Mediterraneo ed i mari italiani, mentre l’inasprimento del “gradiente barico orizzontale” indotto dallo stesso processo ciclogenetico algerino determina un sensibile rinforzo della ventilazione occidentale sul bordo meridionale della giovane area depressionaria che amplifica il flusso d’origine atlantica che entra dalla costa marocchina.
 Se il vortice depressionario si approfondisce rapidamente, con un minimo barico al suolo che scende sotto i 1000 hpa, il fitto “gradiente barico” prodotto sul Sahara algerino, alla base della circolazione depressionaria, va ad attivare una forte ventilazione occidentale, in genere con venti molto intensi da O-SO e Ovest (raffiche fino a 70-80 km/h), che spazza l’intero entroterra desertico algerino, specie la regione dei grandi Erg occidentali (dove sono presenti le grandi dune di sabbia del Sahara), causando delle estese tempeste di sabbia, meglio note con il termine di “Haboob”. Gli “Haboob” quando battono il deserto sabbioso sono in grado di sollevare per aria ingenti quantità di sabbia molto fine e pulviscolo desertico fatto turbinare dalle intense raffiche di vento. Le particelle di polvere e pulviscolo più leggere vengono sollevate a quote particolarmente elevate, sopra i 3000-4000 metri. Raggiungendo tali quote queste nubi di pulviscolo vengono a loro volta agganciate dai sostenuti venti meridionali dominanti lungo il lato anteriore (quello orientale) della circolazione depressionaria nord-africana, i quali tenderanno a spingerle verso l’area mediterranea e l’Italia, in seno alla “Warm Conveyor Belt” (l’enorme sistema nuvoloso che risale davanti il fronte freddo avanzante nel settore pre-frontale di una circolazione depressionaria), costituita da masse d’aria calde e molto secche, d’estrazione sub-tropicale continentale, che tendono a sollevarsi rapidamente, senza permettere di caricarsi di umidità durante il transito sul “mare Nostrum” (ciò comporta una nuvolosità prevalentemente medio-alta costituita da altostrati, altocumuli, cirrostrati).
Se il vortice depressionario si approfondisce rapidamente, con un minimo barico al suolo che scende sotto i 1000 hpa, il fitto “gradiente barico” prodotto sul Sahara algerino, alla base della circolazione depressionaria, va ad attivare una forte ventilazione occidentale, in genere con venti molto intensi da O-SO e Ovest (raffiche fino a 70-80 km/h), che spazza l’intero entroterra desertico algerino, specie la regione dei grandi Erg occidentali (dove sono presenti le grandi dune di sabbia del Sahara), causando delle estese tempeste di sabbia, meglio note con il termine di “Haboob”. Gli “Haboob” quando battono il deserto sabbioso sono in grado di sollevare per aria ingenti quantità di sabbia molto fine e pulviscolo desertico fatto turbinare dalle intense raffiche di vento. Le particelle di polvere e pulviscolo più leggere vengono sollevate a quote particolarmente elevate, sopra i 3000-4000 metri. Raggiungendo tali quote queste nubi di pulviscolo vengono a loro volta agganciate dai sostenuti venti meridionali dominanti lungo il lato anteriore (quello orientale) della circolazione depressionaria nord-africana, i quali tenderanno a spingerle verso l’area mediterranea e l’Italia, in seno alla “Warm Conveyor Belt” (l’enorme sistema nuvoloso che risale davanti il fronte freddo avanzante nel settore pre-frontale di una circolazione depressionaria), costituita da masse d’aria calde e molto secche, d’estrazione sub-tropicale continentale, che tendono a sollevarsi rapidamente, senza permettere di caricarsi di umidità durante il transito sul “mare Nostrum” (ciò comporta una nuvolosità prevalentemente medio-alta costituita da altostrati, altocumuli, cirrostrati).
 Ma lo sviluppo delle nubi di polvere va attribuita anche all’avvezione di vorticità positiva (associata alla ciclogenesi algerina) che si viene ad originare sul versante meridionale dell’Atlante Telliano. Essa produce intense correnti ascensionali capaci di aspirare ingenti quantità di polvere e pulviscolo dall’entroterra desertico algerino, alcune volta persino dal deserto libico e cirenaico. Spesso queste “nuvole di polvere”, muovendosi verso nord in direzione del Mediterraneo, invadono i nostri cieli dando alla coltre celeste quell’aspetto fosco e rossastro. Se accompagnate alle precipitazioni il loro effetto è ancora più visibile visto che aggregandosi agli altri nuclei di condensazione, già presenti all’interno delle nubi, raggiungono il suolo sotto forma di gocce di pioggia sporche, che ricoprono di fanghiglia ogni oggetto ubicato all’aperto. Nei mesi estivi, invece, le nuvole di polvere che interessano il Mediterraneo vengono sollevate dai sostenuti venti orientali che spazzano tutta l’area del Sahara, sul settore a nord della linea dell’ITCZ (“fronte di convergenza intertropicale”) attestata sull’Africa sub-sahariana.
Ma lo sviluppo delle nubi di polvere va attribuita anche all’avvezione di vorticità positiva (associata alla ciclogenesi algerina) che si viene ad originare sul versante meridionale dell’Atlante Telliano. Essa produce intense correnti ascensionali capaci di aspirare ingenti quantità di polvere e pulviscolo dall’entroterra desertico algerino, alcune volta persino dal deserto libico e cirenaico. Spesso queste “nuvole di polvere”, muovendosi verso nord in direzione del Mediterraneo, invadono i nostri cieli dando alla coltre celeste quell’aspetto fosco e rossastro. Se accompagnate alle precipitazioni il loro effetto è ancora più visibile visto che aggregandosi agli altri nuclei di condensazione, già presenti all’interno delle nubi, raggiungono il suolo sotto forma di gocce di pioggia sporche, che ricoprono di fanghiglia ogni oggetto ubicato all’aperto. Nei mesi estivi, invece, le nuvole di polvere che interessano il Mediterraneo vengono sollevate dai sostenuti venti orientali che spazzano tutta l’area del Sahara, sul settore a nord della linea dell’ITCZ (“fronte di convergenza intertropicale”) attestata sull’Africa sub-sahariana.
 In genere queste particelle di polvere, molto leggere e sottili, una volta agganciate dalle correnti ascensionali che si originano nell’area poco a nord dell’ITCZ (dove l’attività convettiva è molto forte), tendono a salire di quota aggirando dal bordo meridionale e occidentale il possente anticiclone sub-tropicale libico-algerino, che in quel periodo dispone i propri massimi barici al suolo ed in quota sull’entroterra desertico algerino, a sud della catena montuosa dell‘Atlante. Quando il promontorio anticiclonico nord-africano si protende sul mar Mediterraneo queste nuvole di pulviscolo risalgono dal suo bordo occidentale per raggiungere la Spagna, il “mare Nostrum” o l’Italia, dove il loro passaggio in quota contribuisce a velare i cieli o a dargli quell’aspetto lattiginoso da tutti osservato. Va anche detto che le nuvole di pulviscolo che interessano il Mediterraneo e l’Europa meridionale non hanno nulla a che vedere, come estensione e durata, con quelle ciclicamente espulse dai venti di “Harmattan” (il corrispondente dell’Aliseo di NE sopra l’area sahariana), dal Sahara occidentale verso l’oceano Atlantico, dove ogni anno vanno a depositarsi ingentissimi quantitativi di polvere desertica. Basti pensare che nel mese di Giugno del 2007 dai deserti del Sahara occidentale era stata espulsa una enorme nuvola di polvere che è stata in grado di offuscare i cieli sopra l’Atlantico tropicale per svariati giorni, contribuendo a raffreddare le acque superficiali oceaniche, con un conseguente rallentamento dell’attività degli uragani e delle tempeste tropicali.
In genere queste particelle di polvere, molto leggere e sottili, una volta agganciate dalle correnti ascensionali che si originano nell’area poco a nord dell’ITCZ (dove l’attività convettiva è molto forte), tendono a salire di quota aggirando dal bordo meridionale e occidentale il possente anticiclone sub-tropicale libico-algerino, che in quel periodo dispone i propri massimi barici al suolo ed in quota sull’entroterra desertico algerino, a sud della catena montuosa dell‘Atlante. Quando il promontorio anticiclonico nord-africano si protende sul mar Mediterraneo queste nuvole di pulviscolo risalgono dal suo bordo occidentale per raggiungere la Spagna, il “mare Nostrum” o l’Italia, dove il loro passaggio in quota contribuisce a velare i cieli o a dargli quell’aspetto lattiginoso da tutti osservato. Va anche detto che le nuvole di pulviscolo che interessano il Mediterraneo e l’Europa meridionale non hanno nulla a che vedere, come estensione e durata, con quelle ciclicamente espulse dai venti di “Harmattan” (il corrispondente dell’Aliseo di NE sopra l’area sahariana), dal Sahara occidentale verso l’oceano Atlantico, dove ogni anno vanno a depositarsi ingentissimi quantitativi di polvere desertica. Basti pensare che nel mese di Giugno del 2007 dai deserti del Sahara occidentale era stata espulsa una enorme nuvola di polvere che è stata in grado di offuscare i cieli sopra l’Atlantico tropicale per svariati giorni, contribuendo a raffreddare le acque superficiali oceaniche, con un conseguente rallentamento dell’attività degli uragani e delle tempeste tropicali.