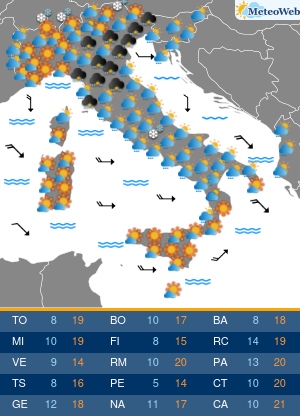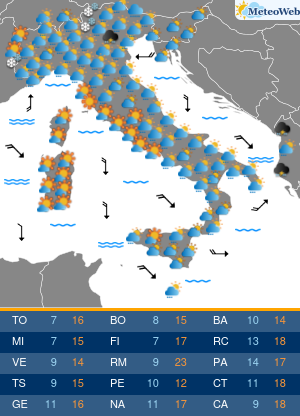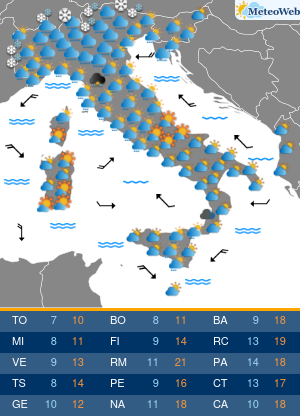Come ben sappiamo, l’autunno è la stagione più piovosa su gran parte del territorio italiano. Proprio in questo periodo i sistemi frontali e i grandi cicloni extratropicali, di origine atlantica, nel loro moto verso est percorrono traiettorie più meridionali, riuscendo ad entrare sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, richiamando su di esso estese avvezioni di aria calda, d’origine sub-tropicale continentale, che passando sopra le ancora calde acque superficiali dei mari tendono notevolmente ad umidificarsi, producendo precipitazioni intense nelle aree esposte ai venti di scirocco, come le regioni tirreniche ed il versante meridionale delle Alpi. In questo tipo di configurazioni la Liguria e l’alta Toscana sono le aree maggiormente soggette ad eventi precipitativi davvero importanti, capaci di provocare gravi criticità al territorio. Purtroppo, ancora una volta, a distanza da un mese dall’ultima alluvione lampo che ha travolto i quartieri orientali di Genova, un’altra disastrosa alluvione si è abbattuta in nottata sull’entroterra del Tiguglio, inondando la cittadina di Chiavari, è stata prodotta dalla sviluppo della solita linea di confluenza in seno a un flusso di umidi e caldi venti di scirocco e ostro, che risalendo dal Tirreno si sono umidificati (essendo molto caldi in origine hanno potuto assorbire un gran quantitativo di vapore acqueo che è stato scaraventato contro le alture dell’Appennino ligure) impattando sulle coste dello spezzino e del genovesato orientale, fino all’area di Rapallo.
Come ben sappiamo, l’autunno è la stagione più piovosa su gran parte del territorio italiano. Proprio in questo periodo i sistemi frontali e i grandi cicloni extratropicali, di origine atlantica, nel loro moto verso est percorrono traiettorie più meridionali, riuscendo ad entrare sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, richiamando su di esso estese avvezioni di aria calda, d’origine sub-tropicale continentale, che passando sopra le ancora calde acque superficiali dei mari tendono notevolmente ad umidificarsi, producendo precipitazioni intense nelle aree esposte ai venti di scirocco, come le regioni tirreniche ed il versante meridionale delle Alpi. In questo tipo di configurazioni la Liguria e l’alta Toscana sono le aree maggiormente soggette ad eventi precipitativi davvero importanti, capaci di provocare gravi criticità al territorio. Purtroppo, ancora una volta, a distanza da un mese dall’ultima alluvione lampo che ha travolto i quartieri orientali di Genova, un’altra disastrosa alluvione si è abbattuta in nottata sull’entroterra del Tiguglio, inondando la cittadina di Chiavari, è stata prodotta dalla sviluppo della solita linea di confluenza in seno a un flusso di umidi e caldi venti di scirocco e ostro, che risalendo dal Tirreno si sono umidificati (essendo molto caldi in origine hanno potuto assorbire un gran quantitativo di vapore acqueo che è stato scaraventato contro le alture dell’Appennino ligure) impattando sulle coste dello spezzino e del genovesato orientale, fino all’area di Rapallo.
 Proprio qui l’umido flusso sciroccale si è trovato la strada sbarrata dalle più fredde correnti di tramontana (masse d’aria d’estrazione padana in scivolamento dall’astigiano e dal cuneese) che già da ieri iniziavano a traboccare dai valichi appenninici del savonese e del ponente di Genova, con i soliti deflussi freschi lungo le vallate dell’imperiese e del savonese. Spesso ad ogni peggioramento, la tramontana si attiva lungo le coste del ponente ligure per ragioni “termo-dinamiche” locali, legate principalmente alla notevole differenza termica fra il versante padano e le coste liguri, solitamente più calde. Lungo la linea di demarcazione fra le differenti masse d’aria, di direzione quasi opposta, l’aria calda e molto umida convogliata dai venti di scirocco, che risalgono dal Tirreno, è stata costretta a sollevarsi di colpo dall’intrusione, nei bassi strati, dei venti freddi di tramontana che uscivano dalle principali valli del savonese e parte del genovesato occidentale. Ciò ha costretto (si tratta di una vera e propria forzatura) l’aria umida marittima, d’estrazione sub-tropicale continentale marittimizzata, ad alzarsi di colpo verso l’alto e ad anticipare il processo di condensazione, favorendo la genesi di grosse cumulogenesi marittime, nel tratto di mare davanti Genova, che hanno poi originato e successivamente continuato a supportare il sistema temporalesco a mesoscala autorigenerante che dopo aver interessato la città di Genova in serata, la scorsa notte è traslato a levante, scaricando veri e propri diluvi sulle alture del Tiguglio e nella zona di Chiavari, determinando la rapida ondata di piena di fiumi e torrenti e l’allagamento dei centri abitati posti sulla traiettoria del sistema convettivo.
Proprio qui l’umido flusso sciroccale si è trovato la strada sbarrata dalle più fredde correnti di tramontana (masse d’aria d’estrazione padana in scivolamento dall’astigiano e dal cuneese) che già da ieri iniziavano a traboccare dai valichi appenninici del savonese e del ponente di Genova, con i soliti deflussi freschi lungo le vallate dell’imperiese e del savonese. Spesso ad ogni peggioramento, la tramontana si attiva lungo le coste del ponente ligure per ragioni “termo-dinamiche” locali, legate principalmente alla notevole differenza termica fra il versante padano e le coste liguri, solitamente più calde. Lungo la linea di demarcazione fra le differenti masse d’aria, di direzione quasi opposta, l’aria calda e molto umida convogliata dai venti di scirocco, che risalgono dal Tirreno, è stata costretta a sollevarsi di colpo dall’intrusione, nei bassi strati, dei venti freddi di tramontana che uscivano dalle principali valli del savonese e parte del genovesato occidentale. Ciò ha costretto (si tratta di una vera e propria forzatura) l’aria umida marittima, d’estrazione sub-tropicale continentale marittimizzata, ad alzarsi di colpo verso l’alto e ad anticipare il processo di condensazione, favorendo la genesi di grosse cumulogenesi marittime, nel tratto di mare davanti Genova, che hanno poi originato e successivamente continuato a supportare il sistema temporalesco a mesoscala autorigenerante che dopo aver interessato la città di Genova in serata, la scorsa notte è traslato a levante, scaricando veri e propri diluvi sulle alture del Tiguglio e nella zona di Chiavari, determinando la rapida ondata di piena di fiumi e torrenti e l’allagamento dei centri abitati posti sulla traiettoria del sistema convettivo.
 Lo scontro fra le differenti masse d’aria (lo scirocco caldo umido e la tramontana più fresca e secca d’origine padana), lungo tutto l’asse della linea di confluenza venti disteso sul Golfo di Genova, ha contribuito ad alimentare un consistente “forcing” convettivo. Creando l’ambiente più che ideale per la nascita di insidiosi sistemi temporaleschi a mesoscala, di forma lineare, come i “V-Shaped”. La caratteristica forma a V di questi temporali, caratteristici della stagione autunnale sul Mediterraneo ed in particolare sul mar Ligure, si sviluppa quando un forte “updraft” penetra fin sulla bassa stratosfera, originando un “overshooting top” che blocca il vento ai livelli superiori, forzando il flusso a divergere intorno ad esso. Giunti in questa fase s’innesca un meccanismo per cui il flusso erode la sommità dell’”updraft” e trasporta i resti della nube temporaleschi nella zona sottovento. Da notare come nei sistemi “V-Shaped” l’area più fredda è vicino all’apice della V, ed è associata all’espansione adiabatica dovuta all’ascesa di aria nell’”updraft” del temporale quando raggiunge la tropopausa. La stazionarietà dei fenomeni è dipesa dalla formazione di un “cold pool” originato dalla discesa di aria fredda del “downdraft” delle varie “Celle temporalesche”, che scivolando lungo i pendii ritornava in mare, dove veniva a contatto con i venti di scirocco ben più caldi, rigenerando nuovi “updraft” e formazione di altre “Cellule temporalesche” verso il Tiguglio.
Lo scontro fra le differenti masse d’aria (lo scirocco caldo umido e la tramontana più fresca e secca d’origine padana), lungo tutto l’asse della linea di confluenza venti disteso sul Golfo di Genova, ha contribuito ad alimentare un consistente “forcing” convettivo. Creando l’ambiente più che ideale per la nascita di insidiosi sistemi temporaleschi a mesoscala, di forma lineare, come i “V-Shaped”. La caratteristica forma a V di questi temporali, caratteristici della stagione autunnale sul Mediterraneo ed in particolare sul mar Ligure, si sviluppa quando un forte “updraft” penetra fin sulla bassa stratosfera, originando un “overshooting top” che blocca il vento ai livelli superiori, forzando il flusso a divergere intorno ad esso. Giunti in questa fase s’innesca un meccanismo per cui il flusso erode la sommità dell’”updraft” e trasporta i resti della nube temporaleschi nella zona sottovento. Da notare come nei sistemi “V-Shaped” l’area più fredda è vicino all’apice della V, ed è associata all’espansione adiabatica dovuta all’ascesa di aria nell’”updraft” del temporale quando raggiunge la tropopausa. La stazionarietà dei fenomeni è dipesa dalla formazione di un “cold pool” originato dalla discesa di aria fredda del “downdraft” delle varie “Celle temporalesche”, che scivolando lungo i pendii ritornava in mare, dove veniva a contatto con i venti di scirocco ben più caldi, rigenerando nuovi “updraft” e formazione di altre “Cellule temporalesche” verso il Tiguglio.
 Ma oltre alla formazione della classica linea di confluenza ligure, fra scirocco e tramontana, il vero responsabile dell’incisività e dell’insistenza di questi fenomeni precipitativi sulle nostre regioni centro-settentrionali è quell’imponente e insistente promontorio anticiclonico di blocco, da settimane ormai preesistente fra il bacino del mar Nero e la Russia europea meridionali, con un solido blocco di geopotenziali alla quota isobarica di 500 hpa che impedisce la naturale evoluzione verso est dell’umido flusso perturbato atlantico. La persistenza di questa importante area anticiclonica, con massimi al suolo sui 1040 hpa fra l’ovest del Kazakistan e la Russia europea sud-orientale, ha rallentato il naturale moto verso est del sistema frontale, favorendo un notevole accumulo di aria umida sul mar Ligure fino alla media troposfera, data la persistenza del settore caldo per oltre 24-48 ore. Fin quando sulla Russia europea e sul mar Nero resisterà questo maestoso anticiclone di blocco, che ergerà la solita azione di blocco al flusso perturbato atlantico, ad ogni peggioramento le regioni tirreniche dovranno fare i conti con sostenuti venti di scirocco e nuove anomalie positive di vapore acqueo che favoriranno grandi potenziali energetici ai fenomeni convettivi in sviluppo fra mar Ligure e mar Tirreno.
Ma oltre alla formazione della classica linea di confluenza ligure, fra scirocco e tramontana, il vero responsabile dell’incisività e dell’insistenza di questi fenomeni precipitativi sulle nostre regioni centro-settentrionali è quell’imponente e insistente promontorio anticiclonico di blocco, da settimane ormai preesistente fra il bacino del mar Nero e la Russia europea meridionali, con un solido blocco di geopotenziali alla quota isobarica di 500 hpa che impedisce la naturale evoluzione verso est dell’umido flusso perturbato atlantico. La persistenza di questa importante area anticiclonica, con massimi al suolo sui 1040 hpa fra l’ovest del Kazakistan e la Russia europea sud-orientale, ha rallentato il naturale moto verso est del sistema frontale, favorendo un notevole accumulo di aria umida sul mar Ligure fino alla media troposfera, data la persistenza del settore caldo per oltre 24-48 ore. Fin quando sulla Russia europea e sul mar Nero resisterà questo maestoso anticiclone di blocco, che ergerà la solita azione di blocco al flusso perturbato atlantico, ad ogni peggioramento le regioni tirreniche dovranno fare i conti con sostenuti venti di scirocco e nuove anomalie positive di vapore acqueo che favoriranno grandi potenziali energetici ai fenomeni convettivi in sviluppo fra mar Ligure e mar Tirreno.