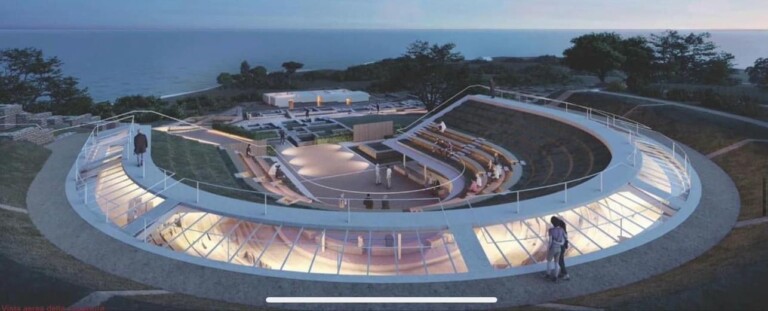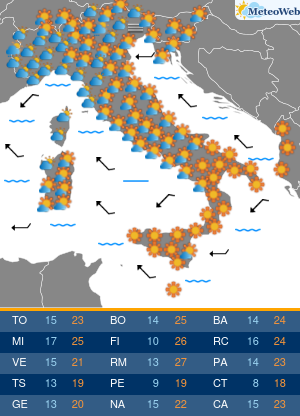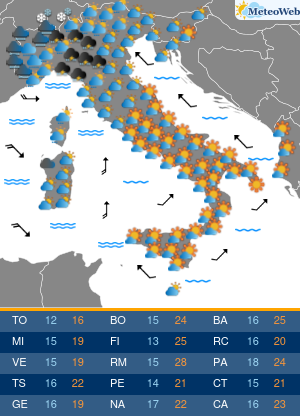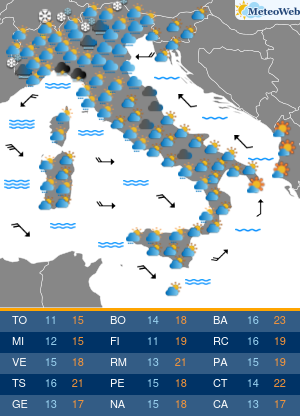Uno dei più importanti fisici del Diciannovesimo secolo nacque oggi, 200 anni fa, ed è il protagonista di oggi del doodle di Google, figurando al posto del classico logo, nella pagina principale del celebre motore di ricerca: si tratta di Anders Jonas Ångström. L’immagine statica rappresenta un elegante signore in abito blu che con la mano sinistra sul mento sembra pensare a qualcosa, reggendo con la mano destra una lampadina la cui luce passa in una nube di gas in cui si intravede la scritta “Google”e attraversa un prisma che la scompone nei colori fondamentali. L’uomo in abito blu è il grande fisico svedese Anders Jonas Ångström, tra i fondatori della scienza della spettroscopia, nato a Lögdö il 13 agosto del 1814 e morto a 59 anni, il 21 giugno 1874, ad Uppsala: famoso in ambito scientifico per i suoi studi sul magnetismo, sul calore, sull’ottica, ma soprattutto per lo studio del fenomeno delle aurore boreali. Nominato a soli 29 anni direttore dell’Osservatorio Astronomico della città di Uppsala, sempre nella stessa città, nel 1858, divenne professore di fisica.
Uno dei più importanti fisici del Diciannovesimo secolo nacque oggi, 200 anni fa, ed è il protagonista di oggi del doodle di Google, figurando al posto del classico logo, nella pagina principale del celebre motore di ricerca: si tratta di Anders Jonas Ångström. L’immagine statica rappresenta un elegante signore in abito blu che con la mano sinistra sul mento sembra pensare a qualcosa, reggendo con la mano destra una lampadina la cui luce passa in una nube di gas in cui si intravede la scritta “Google”e attraversa un prisma che la scompone nei colori fondamentali. L’uomo in abito blu è il grande fisico svedese Anders Jonas Ångström, tra i fondatori della scienza della spettroscopia, nato a Lögdö il 13 agosto del 1814 e morto a 59 anni, il 21 giugno 1874, ad Uppsala: famoso in ambito scientifico per i suoi studi sul magnetismo, sul calore, sull’ottica, ma soprattutto per lo studio del fenomeno delle aurore boreali. Nominato a soli 29 anni direttore dell’Osservatorio Astronomico della città di Uppsala, sempre nella stessa città, nel 1858, divenne professore di fisica.
 In un documento, presentato all’Accademia di Stoccolma nel 1853, non solo evidenziò che la scintilla elettrica produce due spettri sovrapposti, uno per il metallo dell’elettrodo e l’altro per il gas in cui passa, ma dedusse dalla teoria della risonanza di Eulero, che un gas incandescente emette raggi luminosi della stessa capacità rifrattiva di quelli che può assorbire. Questa esposizione, in quanto contenente un principio fondamentale dell’analisi spettrale, venne premiata da Sir Edward Sabine con la medaglia Rumford della Royal Society nel 1872, facendolo rientrare tra i fondatori della spettroscopia. Nel 1862 Angstrom dimostrò, combinando lo spettroscopio con la fotografia, che l’atmosfera del Sole contiene idrogeno e La sua ricerca approfondita sullo spettro solare venne pubblicata, nel 1868, in Recherches sur le spectre solaire (1868), che comprende dettagliate misurazioni di più di mille linee spettrali. Fu, inoltre, il primo fisico, nel 1867, ad esaminare lo spettro dell’aurora boreale , individuando, dalla sua misurazione, la caratteristica linea brillante nella sua regione giallo-verde. In riconoscimento dei suoi contributi alla spettroscopia, l’unità di misura delle lunghezze d’onda delle righe è definita Ångström: (e viene impiegata in cristallografia e in spettroscopia.
In un documento, presentato all’Accademia di Stoccolma nel 1853, non solo evidenziò che la scintilla elettrica produce due spettri sovrapposti, uno per il metallo dell’elettrodo e l’altro per il gas in cui passa, ma dedusse dalla teoria della risonanza di Eulero, che un gas incandescente emette raggi luminosi della stessa capacità rifrattiva di quelli che può assorbire. Questa esposizione, in quanto contenente un principio fondamentale dell’analisi spettrale, venne premiata da Sir Edward Sabine con la medaglia Rumford della Royal Society nel 1872, facendolo rientrare tra i fondatori della spettroscopia. Nel 1862 Angstrom dimostrò, combinando lo spettroscopio con la fotografia, che l’atmosfera del Sole contiene idrogeno e La sua ricerca approfondita sullo spettro solare venne pubblicata, nel 1868, in Recherches sur le spectre solaire (1868), che comprende dettagliate misurazioni di più di mille linee spettrali. Fu, inoltre, il primo fisico, nel 1867, ad esaminare lo spettro dell’aurora boreale , individuando, dalla sua misurazione, la caratteristica linea brillante nella sua regione giallo-verde. In riconoscimento dei suoi contributi alla spettroscopia, l’unità di misura delle lunghezze d’onda delle righe è definita Ångström: (e viene impiegata in cristallografia e in spettroscopia.
 La spettroscopia è un potentissimo metodo di indagine della struttura della materia che si basa sull’ analisi della scomposizione della luce da questa emessa nelle sue lunghezze d’ onda fondamentali. La scomposizione della luce nelle lunghezze d’onda componenti, ottenuta col passaggio attraverso un elemento dispersivo quale un prisma o un reticolo di diffrazione, costituisce lo spettro, ossia l’impronta digitale della sorgente luminosa che ne identifica inequivocabilmente la natura chimica e le condizioni fisiche in cui si trova. La spettroscopia coinvolge quasi tutti i settori della fisica moderna, dall’ ottica ondulatoria, alla teoria atomica. Per mezzo della spettroscopia possiamo comprendere e studiare la composizione chimica del Sole, dei pianeti e delle stelle, rilevare la presenza di campi magnetici delle macchie solari, verificare i meccanismi di formazione dei radicali chimici nella chioma delle comete. Essa ci fornisce anche informazioni sulla presenza dei gas interstellari, permettendoci di di analizzarne la costituzione, misurare la temperatura e la cinetica degli anelli di accrescimento dei sistemi binari, classificare le supernovae, ecc… Su grande scala, la spettroscopia consente la classificazione delle galassie, la misurazione delle velocità di recessione delle quasars, di rilevare il “redshift” degli oggetti celesti, misurando lo spostamento delle righe spettrali in assorbimento od emissione per gli effetti Doppler e relativistico. Senza la spettroscopia, quindi, la moderna astronomia ed astrofisica semplicemente non avrebbero potuto esistere.
La spettroscopia è un potentissimo metodo di indagine della struttura della materia che si basa sull’ analisi della scomposizione della luce da questa emessa nelle sue lunghezze d’ onda fondamentali. La scomposizione della luce nelle lunghezze d’onda componenti, ottenuta col passaggio attraverso un elemento dispersivo quale un prisma o un reticolo di diffrazione, costituisce lo spettro, ossia l’impronta digitale della sorgente luminosa che ne identifica inequivocabilmente la natura chimica e le condizioni fisiche in cui si trova. La spettroscopia coinvolge quasi tutti i settori della fisica moderna, dall’ ottica ondulatoria, alla teoria atomica. Per mezzo della spettroscopia possiamo comprendere e studiare la composizione chimica del Sole, dei pianeti e delle stelle, rilevare la presenza di campi magnetici delle macchie solari, verificare i meccanismi di formazione dei radicali chimici nella chioma delle comete. Essa ci fornisce anche informazioni sulla presenza dei gas interstellari, permettendoci di di analizzarne la costituzione, misurare la temperatura e la cinetica degli anelli di accrescimento dei sistemi binari, classificare le supernovae, ecc… Su grande scala, la spettroscopia consente la classificazione delle galassie, la misurazione delle velocità di recessione delle quasars, di rilevare il “redshift” degli oggetti celesti, misurando lo spostamento delle righe spettrali in assorbimento od emissione per gli effetti Doppler e relativistico. Senza la spettroscopia, quindi, la moderna astronomia ed astrofisica semplicemente non avrebbero potuto esistere.