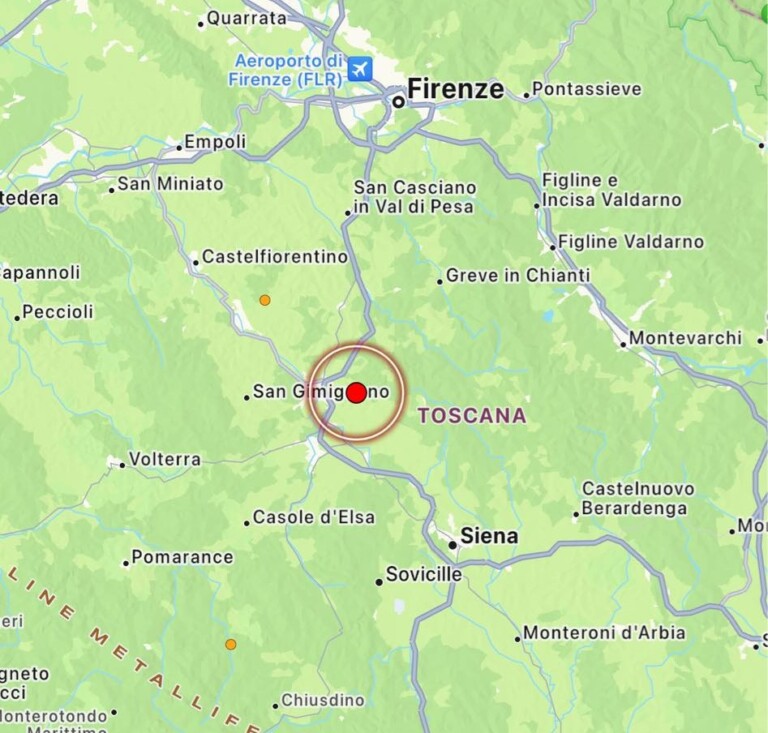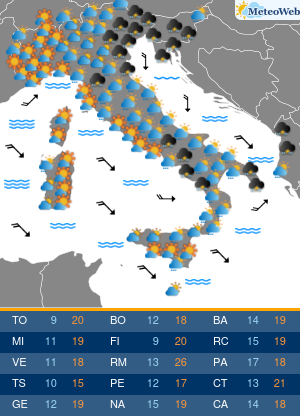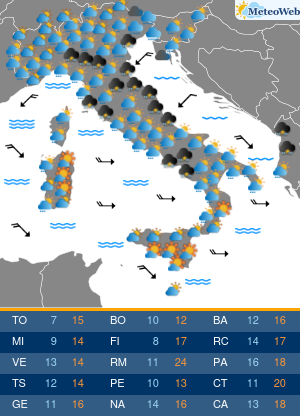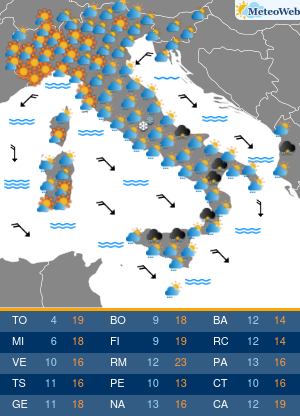Nell’Emilia colpita dal terremoto di domenica scorsas proseguono i sopralluoghi dei geologi volontari che si sono concentrati sui cosiddetti ‘fenomeni locali di sito’, sismici e co-sismici. In particolar sulla liquefazione delle sabbie, i cui punti sono stati individuati e mappati. Sono poi stati raccolti campioni di terreno e sono state fatte analisi sui fluidi presenti nei pozzi, raccolte numerose immagini. Lo ha spiegato Paride Antolini, consigliere nazionale dei geologi che sta seguendo tutte le fasi dei sopralluoghi in atto in Emilia.
Nell’Emilia colpita dal terremoto di domenica scorsas proseguono i sopralluoghi dei geologi volontari che si sono concentrati sui cosiddetti ‘fenomeni locali di sito’, sismici e co-sismici. In particolar sulla liquefazione delle sabbie, i cui punti sono stati individuati e mappati. Sono poi stati raccolti campioni di terreno e sono state fatte analisi sui fluidi presenti nei pozzi, raccolte numerose immagini. Lo ha spiegato Paride Antolini, consigliere nazionale dei geologi che sta seguendo tutte le fasi dei sopralluoghi in atto in Emilia.
”Gia’ in questa fase di rilievi immediatamente successivi alla primissima emergenza si e’ cercato di capire perlomeno qualitativamente se i fenomeni di liquefazione fossero aderenti a quanto riportato alla bibliografia tecnica di riferimento – ha spiegato poi Raffaele Brunaldi, consigliere dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna – ed alle previsioni urbanistiche locali; in una seconda fase l’Ordine dei geologi cerchera’ di trarre conclusioni quantitave relative al descrivere nella maniera piu’ aderente possibile a quanto verificatosi localmente, il fenomeno liquefativo”.
In parole povere, sabbia miscelata all’acqua delle falde alte ha ricoperto per giorni San Carlo, Mirabello e XII Morelli, i paesi costruiti sul letto del vecchio fiume Reno. I residenti, sconvolti, raccontano che questa sorta di “magma” scuro e viscido risale dal sottosuolo trovando sfogo ovunque riesce, distruggendo asfalto e abitazioni dove invece non trova varchi aperti. E’ un mare di melma fuoriuscito sotto la spinta delle onde sismiche, che ha lasciato dietro di sé, in profondità, tunnel e cavità che fanno inclinare i palazzi.
 Il fenomeno ha creato problemi alle fondazioni di alcuni edifici, come spiegano i tecnici accorsi in massa a studiare il ‘caso San Carlo’, unico in Italia a memoria d’uomo. Per questo è stato stilato un programma di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, che coinvolgerà i più importanti enti scientifici italiani. Il panorama, tutto intorno, è desolante. Il meraviglioso e imponente lampadario, donato da Italo Balbo, continua a pendere dallo squarcio del Municipio di Sant’Agostino, ancora in bilico, macabra effigie della precarietà.
Il fenomeno ha creato problemi alle fondazioni di alcuni edifici, come spiegano i tecnici accorsi in massa a studiare il ‘caso San Carlo’, unico in Italia a memoria d’uomo. Per questo è stato stilato un programma di indagini geologiche, geotecniche e geofisiche, che coinvolgerà i più importanti enti scientifici italiani. Il panorama, tutto intorno, è desolante. Il meraviglioso e imponente lampadario, donato da Italo Balbo, continua a pendere dallo squarcio del Municipio di Sant’Agostino, ancora in bilico, macabra effigie della precarietà.
A San Carlo, frazione di Sant’Agostino, particolarmente colpito dal fenomeno, e’ stato allestito tra ieri e oggi un campo per il centinaio di famiglie evacuate per motivi di sicurezza due giorni fa. Gestito dal Dipartimento e dall’associazione volontari della Protezione civile nazionale, il campo puo’ ospitare fino a 250 persone. Ora ne assiste circa cento. Nel paese quello della liquefazione delle sabbia è un vero e proprio nuovo incubo del post-terremoto. Gli abitanti sono 1.800, tantissimi sono “rifugiati” da amici e parenti. Non c’è gas, funzionano a stento solo e acqua. Il gruppo Hera, che gestisce il servizio idrico, non ha mai dichiarato la non potabilità. Ma nessuno si azzarda a bere dai rubinetti.
Le scosse, infatti, hanno dato il via alla liquefazione, un fenomeno che converte il sottosuolo costituito da sabbia e pervaso da acqua, in fango che emerge in superficie creando dei vuoti nel terreno. Ed è in questi vuoti che le case di San Carlo si stanno inabissando.
 La liquefazione è un fenomeno tipico di terreno sabbiosi o limosi ricchi di acqua, insomma costituiti da grani di materia consolidati che creano una struttura solida su cui poggiano le fondamenta degli edifici. Quando si verifica un terremoto la pressione sul sottosuolo aumenta e fa esplodere gli strati superficiali della crosta.
La liquefazione è un fenomeno tipico di terreno sabbiosi o limosi ricchi di acqua, insomma costituiti da grani di materia consolidati che creano una struttura solida su cui poggiano le fondamenta degli edifici. Quando si verifica un terremoto la pressione sul sottosuolo aumenta e fa esplodere gli strati superficiali della crosta.
Le sabbie solide diventano liquide, quasi come sabbie mobili, e spingono verso la superficie. Si crea nel sottosuolo un canale che porta il fango ad eruttare, quasi come fosse un vulcano, ma più fango arriva in superficie, più si amplia il vuoto nel sottosuolo. Un vuoto che una volta riconsolidato non può essere colmato. Il sottosuolo allora non è più in grado di reggere il peso delle costruzioni, e le case e gli edifici cominciano a sprofondare nella cavità sotterranea che si è creata.
Un fenomeno che in Emilia Romagna non era atteso nè si era mai verificato prima: la liquefazione del suolo è un effetto osservato molto spesso per i forti terremoti in Giappone, la cui magnitudo supera i 7 gradi sulla scala Richter. Gian Paolo Cimellaro, uno degli ingegneri del Politecnico di Torino che studia la situazione a San Carlo, ha detto al Corriere della Sera che “abbiamo trovato diverse conchiglie, questa è sabbia di fiume. Con questo terreno, anche la struttura più solida collassa. Succede poche volte, ma qui il fenomeno si è verificato“. Paride Antolini, che coordina i sopralluoghi per cartografare l’Emilia Romagna, ha aggiunto che “nel caso in cui dovesse verificarsi un nuovo sisma di quella intensità la situazione potrebbe peggiorare“. Sempre interpellato dal Corriere della Sera, Enzo Boschi, ordinario di Geofisica della terra solida all’Università di Bologna, ha detto che “dobbiamo immaginare la falda acquifera come una spugna, che è stata strizzata velocemente dal sisma. Il fango è stato disperso, il terreno ha ceduto. La modifica della struttura del suolo, una volta che si asciuga, diventa irreversibile. Ed è molto pericoloso per la stabilità delle costruzioni. Certe case andranno accomodate, altre abbandonate. Questo lo decideranno gli ingegneri. Di sicuro c’è stata una sottovalutazione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel 2003 una mappa di pericolosità sismica e queste zone erano state tutte classificate. Bisognava porsi il problema allora. Questi paesi della Val Padana sono stati costruiti sui depositi alluvionali del Po“.
San Carlo di Sant’Agostino sta sprofondando, il fenomeno è irreversibile, le speranze degli abitanti di tornare nelle loro case sono un lontano miraggio. E intanto la terra continua a tremare: le nuove scosse non possono che aggravare la situazione.
Un disastro nel disastro.