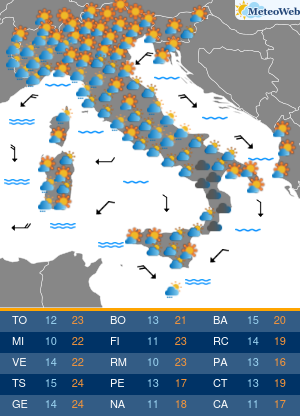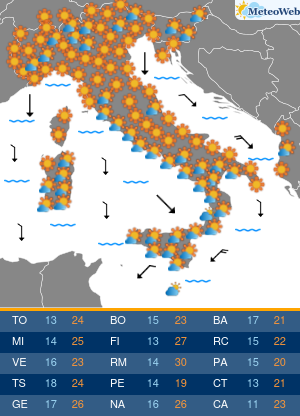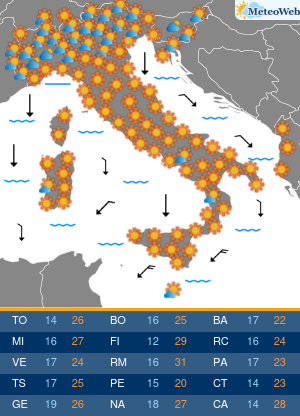A cura di Sofia Baranello e Caterina Zei (INGV), con la collaborazione del gruppo di lavoro del CFTILab
Gli effetti del terremoto
Secondo le testimonianze la scossa del 20 febbraio, che fu avvertita fortemente in tutta la Sicilia e, più leggermente, nella Calabria meridionale e a Malta, diede l’avvio a un periodo sismico, che proseguì fino all’aprile dello stesso anno con numerose repliche più leggere, intervallate da qualcuna forte o molto forte, avvertite nella zona catanese. Tra le scosse più violente, avvenute dopo la principale, è da menzionare quella delle 2:45 UTC del 1 marzo. La scossa, con una magnitudo pari a circa 5.5 (stima da dati macrosismici), colpì in particolare la regione iblea, nella Sicilia orientale, e fu avvertita fortemente nell’Acese e a Catania, con risentimento fino a Palermo, dove fu lieve. Le località più gravemente danneggiate furono Militello in Val di Catania (CT), Mineo (CT), Ragusa e Vizzini (CT), e numerosi altri centri dove causò danni rilevanti.
Lo studio approfondito della documentazione archivistica evidenzia che l’evento del 20 febbraio 1818 e quello del 1 marzo successivo furono originati da strutture sismogenetiche relativamente distanti e almeno apparentemente indipendenti. Lo si evince dal confronto mostrato in Figura 2, ottenuto grazie al tool online per il confronto tra terremoti disponibile sul portale del CFTILab. In altre parole, da un punto di vista sismotettonico i due eventi sembrerebbero del tutto indipendenti l’uno rispetto all’altro: uno strettamente etneo, l’altro di pertinenza iblea. Considerando però la presumibile profondità ipocentrale delle due scosse, per come può essere stimata a partire dai dati di intensità – circa 8-10 km per quella del 20 febbraio, e forse poco di più per quella del 1° marzo – entrambi i terremoti possono essere considerati di tipo tettonico in senso stretto e, soprattutto per quanto riguarda quello catanese, senza alcun collegamento con il complesso vulcanico dell’Etna.

Inoltre, analizzando i dati HSIT (Hai Sentito il Terremoto) del terremoto registrato il 23 dicembre 2021 a Motta sant’Anastasia (CT), si nota una somiglianza nella distribuzione delle intensità con quelle causate dalla scossa del 20 febbraio 1818. Secondo questa considerazione, questa scossa potrebbe essere stata localizzata, sulla base dei dati macrosismici disponibili, più a nord rispetto al suo reale epicentro, presumibilmente a causa di una forte variabilità azimutale della propagazione delle onde sismiche.
I maggiori effetti di danno del terremoto del 20 febbraio 1818, stimati pari al IX-X grado di intensità della scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg), furono rilevati nell’immediato entroterra di Acireale, dove le borgate di Aci Consolazione e Aci Santa Lucia furono pressoché completamente distrutte. Crolli estesi a gran parte dell’abitato si verificarono anche ad Aci Catena, Aci Platani, Aci San Filippo e Aci Sant’Antonio. Complessivamente quasi 60 centri, compresi alcuni paesi dei versanti settentrionale e occidentale dell’Etna, subirono crolli di edifici o danni generalizzati al patrimonio edilizio e altre 40 località subirono danni più leggeri.
Purtroppo, nel valutare gli effetti di questi terremoti va considerato che le scosse, di per sé già molto violente, trovarono un patrimonio edilizio reso fragile dall’utilizzo di materiali e tecniche costruttive di qualità scadente, che determinarono una amplificazione dei danni. Ne è un esempio la città di Catania dove, secondo quanto attestano le perizie, gli edifici più colpiti dal terremoto furono quelli caratterizzati da evidenti e gravi difetti di costruzione. Molte case, infatti, non erano dotate di fondamenta sufficientemente solide; altre invece, erano state sopraelevate o ampliate in un secondo momento, causando uno squilibrio tra la mole della costruzione e le sue fondazioni, senza che queste fossero consolidate. Tutto ciò avvenne nonostante la città fosse anche stata interamente ricostruita dopo il terremoto del 1693, e quindi “nuova” dal punto di vista dello stato di conservazione del patrimonio edilizio. Nonostante molti contemporanei avessero individuato nella fragilità dell’edificato una concausa della gravità dei danni, nelle fasi di ricostruzione e riparazione, che furono lunghe e difficoltose, prevalsero spesso gli interessi dei singoli. A dispetto della sorveglianza operata dalle locali commissioni istituite ad hoc per vigilare sull’accuratezza dei progetti di restauro e sulla qualità dei materiali utilizzati, in molti casi i proprietari approfittarono dell’emergenza per espandere le loro proprietà e aumentare le cubature degli edifici, invece di seguire criteri costruttivi che limitassero i danni che sarebbero potuti derivare da futuri terremoti.
Oltre ai danni causati agli edifici privati e alle infrastrutture, la scossa principale ebbe numerosi effetti sull’ambiente naturale. Secondo osservatori diretti, per tutta la giornata del 20 febbraio le acque nel golfo e nel porto di Catania subirono oscillazioni di modesta entità, accompagnate da un “ribollimento” della superficie e, secondo alcuni, anche da un aumento della temperatura. Numerose e profonde spaccature si aprirono nel terreno in tutta l’area epicentrale, e nella piana a sud di Catania, in località Primosole (“Paraspolo” nelle fonti), furono rilevati anche effetti di liquefazione.
Per conoscere ulteriori dettagli sugli effetti di questo terremoto è possibile consultare la relativa pagina del CFTI5Med. Tale studio del CFTI è il riferimento dell’attuale versione del Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani (CPTI15) e del relativo Database Macrosismico Italiano (DBMI15).
Le fonti storiche
Nell’ambito delle ricerche che hanno portato alla compilazione del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (CFTI5Med), è stato condotto un ampio studio bibliografico e archivistico, per il quale il terremoto risulta ben documentato.
Presso gli Archivi di Stato di Catania e di Palermo è stata reperita una grandissima quantità di documenti e testimonianze, che hanno consentito una buona definizione delle località colpite e dei danni subiti. Questo materiale è risultato, inoltre, particolarmente importante per conoscere in modo approfondito il quadro di riferimento relativo agli aspetti sociali, politici e amministrativi, e comprendere quindi le conseguenze del terremoto sui vari aspetti della vita e dell’attività umana. Sempre in quest’ottica, particolarmente utili si sono rivelate sia le perizie dettagliate relative a centri abitati o a singoli edifici, che accompagnano la documentazione fiscale e amministrativa, sia le disposizioni impartite dagli organismi tecnici ufficiali sui criteri da seguire per la ricostruzione e la riparazione degli edifici. Come immaginabile dall’estensione e dalla gravità dei suoi effetti, il terremoto catanese ebbe una grande risonanza anche oltre i confini regionali. La notizia infatti fu riportata da cinque testate giornalistiche del nord d’Italia. Anche l’eco suscitata tra gli uomini di cultura del tempo fu molto vasta, lasciandoci una mole di testimonianze indipendenti, sia edite che manoscritte, saggi, cronache e memorie, in parte sconosciute alla storiografia sismologica, che sono state reperite nel corso delle ricerche nelle più importanti biblioteche siciliane.
Curiosità
Tra i numerosi effetti indotti dal terremoto sull’ambiente naturale è interessante notare l’aumento dell’attività delle salse di Paternò: elementi naturali caratterizzati da emissione di acqua salata (salsa), generalmente a temperatura ambiente, insieme a fango, gas ed idrocarburi liquidi.
Come fu descritto nella Memoria storico-fisica sul tremuoto de’ 20 febbraio 1818 dal fisico e naturalista catanese Agatino Longo (1818), a seguito della scossa principale “le acque che scorrono presso Aci-Catena … si accrebbero in massa. Ugualmente rimarchevole fu l’aumento delle scaturigini di acque salse, che sono presso Paternò. In vicinanza di queste scaturigini … sgorgò simultaneamente un’acqua salsa, lumacciosa, e di odore di zolfo. Essa formò un rialto di terra conico alto circa palmi 2, di una base proporzionata all’altezza, e cavo sino alla profondità di un palmo”.
Queste manifestazioni naturali, situate all’interno del territorio di Paternò e conosciute fin dall’antichità, fanno adesso parte del geosito “Salinelle di Paternò” della Regione Sicilia (Figura 3). La loro peculiarità risiede nel fatto che “le emissioni fluide, differentemente da altri siti simili, sono originate dalla commistione tra gas magmatici/ idrotermali, che costituiscono la maggior parte della fase gassosa emessa, e gas crostali provenienti da serbatoi di idrocarburi” (Giammanco et al., 2016).

Per conoscere tutti gli studi e i cataloghi che trattano il terremoto descritto si rimanda all’Archivio Storico Macrosismico Italiano.